Il fenomeno che rende conto del colore del cielo è la diffusione (scattering) della luce del Sole da parte delle molecole dell’aria (principalmente ossigeno ed azoto). Per capire come opera la diffusione, pensiamo ad un insieme di molecole, che possiamo raffigurare come oscillatori in grado di assorbire e riemettere le onde elettromagnetiche che li investono. Il fatto è che le molecole non rispondono allo stesso modo a tutte le frequenze incidenti: per particolari frequenze si ha risonanza, vale a dire che la molecola oscilla con notevole ampiezza, mentre per altre frequenze non ci sarà alcuna risposta. Le molecole dell’aria hanno una risposta alla radiazione incidente che varia con la quarta potenza della frequenza. Se pensiamo che la luce visibile ha una lunghezza d’onda compresa tra i 400 nanometri del violetto ed i 700 nanometri del rosso, un rapido calcolo mostra che rispetto alla luce rossa, la luce blu è più diffusa dall’aria di un fattore (700/400)4=10.
Allora, se immaginiamo la luce proveniente dal Sole, che assumiamo essere bianca, vale a dire la miscela di tutte le frequenze visibili, allora la componente blu subirà una maggiore diffusione, vale a dire sarà assorbita e riemessa
molto più della luce rossa. Ciò implica che lungo la linea di vista vedremo la luce bianca del Sole a cui è stata tolta la componente blu, la quale è stata diffusa in direzioni casuali. Per questo motivo, lontano dal Sole, ai nostri occhi arriva quella luce blu che è stata diffusa dalle molecole dell’atmosfera, come mostra lo schema seguente.
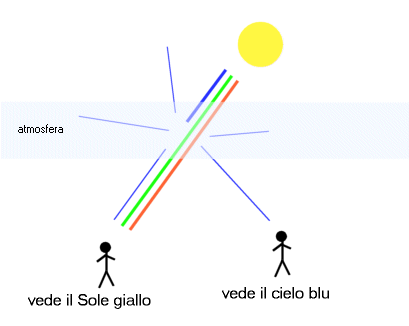
Cosa succede invece al tramonto? Lo spessore dell’atmosfera che si frappone tra noi ed il Sole è molto maggiore di quello diurno, pertanto questo effetto sarà molto più pronunciato, la componente blu sarà sempre più affievolita,
ed il Sole apparirà giallo, e anche la componente verde sarà fortemente attenuata, per cui il Sole apparirà arancione o addirittura rosso. Si noti che ciò non dipende dall’inquinamento atmosferico: anche in una atmosfera
perfettamente pulita il tramonto sarebbe comunque arrossato.
Come esperimento, si può prendere un vaso di vetro non colorato contenente acqua pura, sistemare dietro di esso una forte luce bianca, ed osservare come varia il colore quando aggiungiamo all’acqua delle particelle in grado di diffondere la luce visibile, ad esempio delle gocce di latte o di sapone. Lungo la linea di vista la luce della lampada apparirà arrossata, mentre lateralmente riusciremo a scorgere la componente blu, diffusa dalle particelle in sospensione.
Molto raramente, quando le eruzioni vulcaniche scagliano in atmosfera una enorme quantità di pulviscolo, la Luna appare blu. Il motivo, ancora una volta, è da ricercarsi nella diffusione della luce da parte di queste particelle, le quali diffondono maggiormente la componente rossa della luce.